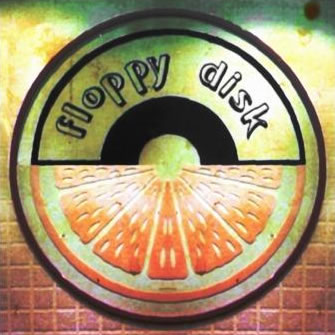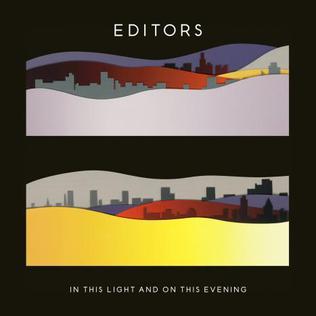Sicuramente questo per un bel pezzo sarà il disco più oscuro recensito su questo blog. Chi sono dunque i
Tricycle? Questo nome non dirà niente ai profani, e questa volta, probabilmente non dirà nemmeno niente agli esperti di musica pop rock anni 60, perché questo disco è davvero raro.
Ma per comprenderlo meglio è necessario fare un passo indietro. Negli anni 60 esisteva un genere musicale chiamato Bubblegum Music, ovvero il padre della terribile musica truzzoide che c'è ai giorni nostri.
Per inciso, mentre i Beatles, i Mothers of Invention, i Doors, Jimi Hendrix e chi più ne ha più ne metta parlavano di amore, di lotta, di critica sociale, di poesia o di qualsiasi altro argomento sensato, gruppi come i 1910 Fruitgum Company, gli Ohio Express, i Kasenetz-Katz Singing Orchestral Circus e altri, facevano canzoni che parlavano (sembra stupido dirlo, ma è vero) di caramelle gommose et similia. Non solo, ma la Bubblegum Music è stata anche la fondatrice del paraculismo musicale: infatti come accadde negli anni 80 con Den Harrow e Milli Vanilli, spesso non era nemmeno il gruppo a cantare, ma session man della casa discografica (addirittura a nome 1910 Fruitgum Company uscì pure un album intitolato
"Hard Ride", che suonava come un disco hard rock!). L'unica nota gaia di tutta questa faccenda erano le b-side dei singoli: spesso per evitare che anche la b-side diventasse una hit (e quindi vendesse di meno il singolo) mettevano qualcosa di completamente inascoltabile, tipo un brano registrato al contrario, o un brano rallentato, oppure qualche canto da ubriacone su una base suonata a caso.
I Trycicle si distinsero dagli altri gruppi di Bubblegum Music, perché rivisitavano in chiave ironica, a volte con venature di hard rock o psichedelia, hit già esistenti. Purtroppo però il risultato era poco interessante per i fan del rock psichedelico, e troppo dissacrante per i fan della Bubblegum Music, e dopo questo album omonimo sparirono così come erano venuti. I musicisti hanno infatti tutti nomi che nulla dicono, probabilmente si sono tutti ritirati dal mondo della musica dopo questo disco.
In effetti, l'album è molto meno interessante di quanto possa sembrare benché vi sia presente qualche momento di rilevo. Spesso gli arrangiamenti ironici (con citazioni a Yankee Doodle o cose simili), purtroppo non si discostano molto dalla musica Bubblegum originale, e non si può certo parlare nemmeno di grandissime doti strumentistiche, a parte i cori che sono ben amalgamati.
Così, brani come
"Lemonade Parade",
"54321 Here I Come",
"Yumberry Park" e
"Yellow Brick Rainbow" risultano parecchio inutili, perché nel loro stile parodistico non risultano differenti dai vari successi zuccherosi (letteralmente) del genere. Qualche sprizzo di ironia si ha in
"Good Time Music", nel quale i Tricycle sembrano voler giocare a fare i Mothers of Invention di "Absolutely Free", ma a parte questo e una curiosa imitazione di Donald Duck il brano ha ben poco da offrire, così come pur nella sua gradevolezza, ci si dimentica facilmente anche dell'opener
"Mr. Henry's Lollipop Shop". I Beatles vengono scimmiottati in
"Mary Had A Little Man", ma il risultato finale è ben lungi dalla perfezione.
I tre brani rimanenti sono i più interessanti, che salvano l'album dal baratro totale. La rivisitazione del classico dei 1910 Fruitgum Company
"Simon Says" (nota in Italia come "Il ballo di Simone" e interpretata da Giuliano e i Notturni), benché sia uno spudorato plagio ai Pink Floyd (soprattutto gli inserti chitarristici) è sicuramente superiore all'originale, con una lunga acid jam. Di buona fattura anche la sperimentale
"It's A Game", nella quale i musicisti, timidamente, osano di più e giocano con diversi ritmi. Il brano di chiusura, però, è sicuramente il migliore, la cupa
"Poor Old Mr. Jensen": la storia della morte di una anziana persona malata sicuramente è un modo atipico di chiudere un album che parla di caramelle gommose. Parte come un brano psichedelico tipico dell'epoca, prima di trasformarsi in una strofa dalla melodia parecchio triste e cupa dominata dalla voce e dall'organo. Segue poi un intervento chitarristico relativamente interessante per i canoni del disco, per poi riprendere la strofa e chiudere il brano. Molto belli i cori, che come ho già detto prima, sono probabilmente l'unica cosa di cui il gruppo può vantarsi.
L'idea di base era buona, ma purtroppo in moltissimi casi ci si è limitati a copiare il genere più che a riarrangiarlo, e ciò non va a favore del disco. Un peccato, perché brani come
"Poor Old Mr. Jensen" dimostrano che questo disco avrebbe almeno potuto essere decente.
Questo album è rarissimo, è fuori stampa dal 1969 e non è nemmeno mai stato stampato in CD, ma trovarne una copia su ebay o su programmi di sharing non è un impresa impossibile.
Voto: 4.5