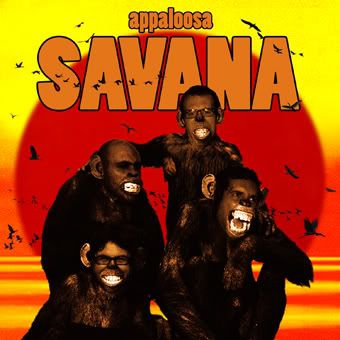E' arrivato il nuovo anno e del 2009 già ho scritto, e come me gli altri autori del presente blog, ciò che ho apprezzato e cosa invece mi ha deluso nel panorama delle uscite musicali in ambito rock e dintorni.
Come per ogni anno che comincia gradirei mettere per iscritto quali sono le mie aspettative, musicalmente parlando, così magari anche chi legge può commentare e dire cosa gli piacerebbe sentire o magari vedere recensito su queste pagine.
Cominciamo dai live dato che ho appreso in questi giorni che avremo in Italia gli
AC/DC (in maggio saranno a Udine) e che non si fermeranno i
Pearl Jam durante il loro tour europeo.
Mi piacerebbe tornassero i
Coldplay, che quest'anno me li son persi, o che passassero i
Creed anche se per ora non ho trovato nuove in tal senso.
Ci sono invece date certe per i
Muse e
Mark Knopfler che arriveranno in estate rispettivamente con il “Revelations Tour” e con il “Get Lucky Tour” mentre faranno due concerti (6 agosto a Torino e 8 ottobre a Roma) gli
U2 dopo il tutto esaurito di quest’anno.
Ritorno importante sarà anche quello dei
Pixies, pietre miliari del rock indie a stelle e strisce, che saranno a Ferrara il 6 giugno: una bella occasione per vedere uno dei gruppi che hanno influenzato gente come i
Nirvana e, più in generale, tutta quella scena di grunge e alternative rock nato negli anni novanta.
Per gli amanti del metallo arriveranno anche i
Mastodon, questa volta con un proprio tour e non di spalla a qualche mostro sacro (leggi
Metallica ad esempio), per portare in giro “Crack the Skye”: un album che non si ferma al metal ma che spazia anche nel progressive e nella psichedelìa.
Notizia interessante è anche quella, sempre restando in argomento di concerti, che i
Litfiba si riuniranno per un pugno di date il prossimo aprile (Milano, Firenze, Roma e Acireale), anche se al momento non ci sono rumors riguardo un nuovo disco.
Staremo a vedere!
Per quanto riguarda le uscite discografiche mi piacerebbe sentire un nuovo disco targato
Tool, ma ho paura che anche questa volta faranno aspettare a lungo i loro fans.
In rete ho invece trovato anticipazioni sulle uscite di
Stereophonics (gennaio) e
HIM (febbraio).
L’album dei primi si intitolerà “Keep Calm & Carry On” , mentre il nuovo della band finlandese si chiamerà “Screamworks” e verrà anticipato dal singolo “Heratkiller”; il loro tour partirà a marzo dalla Gran Bretagna.
L’artiglieria pesante si farà sentire con
Deftones (in uscita a febbraio il loro “Eros”),
Soulfly (“Omen” in arrivo dalla Roadrunner ad aprile),
Limp Bizkit (“Gold Cobra” in stampa a maggio) e nientemeno che
Rob Zombie, che uscirà a febbraio con il nuovo lavoro che si annuncia ricco di ospiti.
A fine gennaio poi si tornerà a parlare di
Beatles (è di questa fine 2009 il disco dal vivo di
Paul McCartney) perché uscirà per la Universal un nuovo lavoro di
Ringo Starr.
E in Italia?
In Italia si parla di
Pino Scotto (!!!) perché sembra sia in studio per registrare un nuovo album insieme a misteriosi quanto interessanti ospiti…
Di italiano non ho trovato altro in ambito rock, ma mi auguro emerga qualche realtà nuova che non arrivi dai soliti talent show, che a mio parere servono solo a far pubblicare brani ad autori di secondo piano che altrimenti dovrebbero andare a lavorare per davvero.
Magari uscisse anche qualcosa di
Afterhours,
Marlene o
Subsonica, gruppi italiani considerati alternativi (ma alternativi a che?) ed eterni emergenti malgrado abbiano alle spalle ormai anni di successi.
E per concludere prego (per quanto conti la mia opinione) gli artisti mainstream di qualunque nazionalità a non pubblicare cover inutili solo per vendere dischi altrimenti vuoti di idee e contenuti: prendetevi un anno sabbatico per far surf come fa
Eddie Vedder tra un disco e l'altro e forse qualche buona idea verrà anche a voi che suonate “Personal Jesus” in mille salse.
 I No Seduction, trio della provincia di Venezia (Chioggia per la precisione), rilascia un EP dal titolo ironico, “S.P.U.P.P.A”, sparando in faccia al potenziale ascoltatore appena cinque tracce (più cinque remix) di dance-punk come qualche band inglese già ha fatto, ma con un approccio minimale e volutamente “simpatico” che stupisce. A chi ha ascoltato i Klaxons o i nostri connazionali Trabant, un po' di electro rock come si deve, sempre dal Triveneto.
I No Seduction, trio della provincia di Venezia (Chioggia per la precisione), rilascia un EP dal titolo ironico, “S.P.U.P.P.A”, sparando in faccia al potenziale ascoltatore appena cinque tracce (più cinque remix) di dance-punk come qualche band inglese già ha fatto, ma con un approccio minimale e volutamente “simpatico” che stupisce. A chi ha ascoltato i Klaxons o i nostri connazionali Trabant, un po' di electro rock come si deve, sempre dal Triveneto.